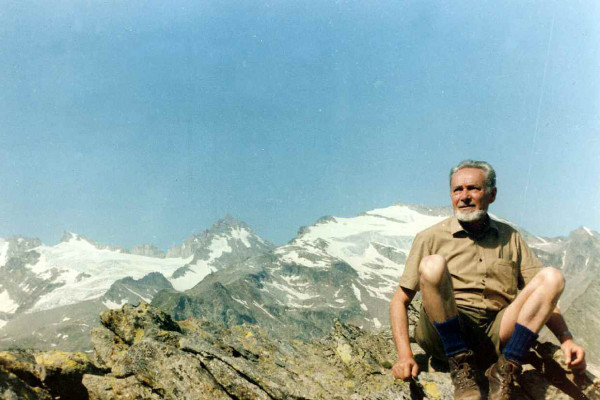NESSUNO PRONUNCI IL SUO NOME INVANO
di Marcello Maddalena
(Estratto dal discorso per la commemorazione ufficiale dei 25 anni dell’omicidio di Bruno Caccia, pronunciato presso il Palazzo di Giustizia di Torino – 26 giugno 2008)
Ho riesumato dal sacrario dei miei ricordi questi episodi e questi esempi solo per far comprendere come Bruno Caccia non fosse e non sia di nessuno, perché appartiene a un’altra sfera, a un’altra dimensione, ad altre altezze e a nessuno è consentito appropriarsene. Nessuno pronunci il suo nome invano.
Sono passati venticinque anni. Ma per chi, come il sottoscritto, ha avuto il privilegio di conoscere Bruno Caccia e di stargli accanto, sono stati venticinque anni di un colloquio ideale che è sempre continuato e che è sopravvissuto alla morte fisica.
Sono cambiati i tempi, sono cambiate le mode, i costumi, le persone, ma sono rimasti i sentimenti, i valori, gli ideali: i valori veri, quelli per cui una vita merita di essere vissuta, che non sono cancellati dalla morte del corpo e che consentono a chi è rimasto di continuare a colloquiare con chi se n’è andato. Un colloquio senza parole, senza sguardi, senza presenza fisica; ma non per questo meno intenso, meno reale, meno vero. Un colloquio che si è nutrito e si nutre di comunanza di affetti e di ideali. E che ha fatto sì che, nello scorrere del tempo, nel susseguirsi delle vicende umane, nell’esplodere delle tempeste che in questi venticinque anni hanno contrassegnato e continuano a miseramente contrassegnare la vita della nazione, l’evolversi della legislazione e lo sviluppo della giurisdizione, la voce di Bruno Caccia sia stata continuamente sentita da chi lo ha conosciuto e ha voluto sentirla. Una voce solitaria, una voce fuori dal coro, la voce di un uomo, di cui nessuna parte e nessun colore politico, nessuna componente sociale, nessuna corrente associativa può avere l’ardire di tentare di appropriarsi.
Ricordo qui, come ho ricordato in altra occasione, la sua concezione sacrale dello Stato, delle Istituzioni, della Giustizia, da chiunque fossero rappresentate. Concezione sacrale che lo condusse a dimettersi dall’Associazione Nazionale Magistrati nel momento in cui proclamò il primo sciopero dei magistrati, di cui pure condivideva le ragioni di fondo. Per lui non era concepibile che la magistratura, che è e deve essere un potere dello Stato, scioperasse, come non è possibile che scioperi e non dica messa il sacerdote. Non c’erano per lui né ragioni economiche né ragioni politiche che valessero a giustificarlo. Quale che fosse il governo o la maggioranza parlamentare nel Paese. A quell’epoca ero tesoriere della giunta della locale A.N.M.; ricordo che venne da me, pretese di corrispondere fino all’ultima lira tutto quello che doveva versare come “quota associativa” e mi presentò la lettera di dimissioni. Ovviamente irrevocabili, come sono o dovrebbero essere irrevocabili le dimissioni delle persone serie.
Ricordo la sua profonda convinzione che il magistero penale dovesse servire, da un lato, a difendere la società da coloro che, commettendo delitti, erano per la stessa pericolosi (i soggetti socialmente pericolosi) e, dall’altro, a rieducare il condannato come stabilisce la carta costituzionale; e come, in quest’ottica, fosse fondamentale la netta distinzione tra i soggetti incensurati e i recidivi. Al punto che controllava personalmente che sulle richieste e sui decreti di citazione a giudizio fosse ben annotata, contestata ed evidenziata la recidiva e l’esistenza delle condizioni che consentivano al giudice di dichiarare l’eventuale condannato “delinquente abituale o professionale o per tendenza”, e se un sostituto si dimenticava questa contestazione, l’aggiungeva lui personalmente a penna. Perché il principio rieducativo permette che prima si perdoni, poi si condoni (non nel senso del condono del 2006), ma a un certo punto ci si decida a “bastonare”.

A San Sebastiano Po (non lontano da Chivasso, To) sorge la villa che fu della famiglia di Domenico belfiore, mandante dell’omicidio caccia. Confiscata dallo Stato nel 1999, è oggi gestita da Libera, i cui operatori e volontari, per lo più giovanissimi, stanno restituendo alla società un luogo per anni simbolo dell’illegalità mafiosa al Nord. (Foto di Dario Ferro)
Ricordo ancora il suo assoluto rispetto per quello che allora si chiamava “segreto istruttorio”. È rimasta celebre e riportata nel libro di un giornalista sulle Brigate rosse la frase da lui indirizzata ai giornalisti che lo pedinavano e inseguivano mentre a piedi si dirigeva verso la Corte d’Appello: “Correte, correte, tanto non vi dico niente”. Per lui, quello che il legislatore dichiarava segreto, doveva restare segreto, al punto che era assolutamente contrario al riconoscimento del “segreto professionale” per l’attività giornalistica: perché occultare la fonte delle notizie, significava licenza di diffamazione e calunnia (ovviamente, da parte della fonte) con garanzia di impunità.
Ricordo come, per lui, fosse assolutamente sacro il principio per cui il magistrato, fosse esso pubblico ministero o giudice, dovesse ricercare solo ed esclusivamente la verità. La verità sostanziale, non quella meramente processuale. Con coraggio, anche a costo di sfidare l’impopolarità, l’incomprensione, l’ironia, il dileggio. In quest’ottica, come ho ricordato in altra occasione, ai tempi in cui le Brigate rosse venivano fatte passare per “nere” e alcuni magistrati che troppo indagavano sul traliccio di Segrate venivano invitati da altri colleghi a “fare autocritica”, così serenamente scriveva nella requisitoria al termine della istruzione formale contro il nucleo storico delle Brigate rosse: “Dell’esistenza di tale associazione (che taluni, non si sa se in buona fede, si sono ostinati a chiamare “fantomatiche” o “sedicenti”) parlano di per sé i fatti… Come sempre la storia si ripete, ma mai in modo identico, le ideologie e le prassi si confondono; onde non può destare meraviglia che molte azioni delle Br abbiano un contenuto prettamente squadristico del più classico stampo del fascismo dei primi anni, mentre l’estrazione degli associati è tutta di estrema sinistra e le loro pubblicazioni hanno tutte una ispirazione nettamente marxista o, come essi la qualificano, comunista”. Questa valutazione oggi fa parte della storia; a quell’epoca, per scrivere queste cose ci voleva del coraggio. Anzi, molto coraggio. Che non tutti, anche tra i magistrati, hanno avuto.
Sempre in quest’ottica, della ricerca della verità e della riaffermazione della legalità, non esitò ad avviare, subito dopo il suo insediamento a Procuratore della Repubblica di Torino, un procedimento penale, passato anch’esso alla storia, per reprimere i fatti di reato, le violenze e i pestaggi che puntualmente si verificavano in occasione di ogni sciopero, per conculcare, in omaggio al diritto di alcuni, l’esercizio da parte di altri dell’altrettanto importante diritto al lavoro.
E ricordo ancora il processo cosiddetto “Zampini”, avviato – su coraggiosa iniziativa, che va doverosamente ricordata e additata ad esempio, dell’allora sindaco di Torino Diego Novelli – nei confronti delle prime manifestazioni di Tangentopoli: primizia delle inchieste e dei procedimenti del genere e dimostrazione, testimonianza e riaffermazione che la legge è uguale per tutti e da tutti va rispettata.
Per lui, una separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici – soggetti inscindibilmente accomunati, nella sua e nostra ottica, dalla comune ricerca della verità – sarebbe stata assolutamente impensabile, come lo sarebbe stata anche la più modesta riforma dell’ordinamento giudiziario. Ricordo che, arrivato da poco alla Procura della Repubblica come sostituto, mi mandò a sostenere l’accusa in un processo di omicidio in cui avevo redatto, da giudice istruttore, l’ordinanza di rinvio a giudizio; alla mia prospettazione di inopportunità di una simile designazione, rispose che l’imparzialità è un attributo dello spirito e una qualità personale e non un connotato del ruolo e della funzione. A proposito della quale aggiungeva che lui, da pubblico ministero, non aveva mai chiesto una condanna o una pena che non avrebbe inflitto da giudice. Perché concepiva il ruolo del pubblico ministero con la mentalità e la deontologia del giudice, e questa mentalità e questa deontologia cercava di trasmettere e trasmetteva ai suoi sostituti.
In quest’ottica, spesso ammoniva i suoi giovani magistrati (che adorava, perché adorava i giovani e adorava i magistrati giovani) a ricordare che “un avvocato è sempre un avvocato”. Nel che non v’era il minimo disconoscimento, la minima mancanza di rispetto nei confronti di un ruolo e di una professione che massimamente teneva in considerazione, ma unicamente una sottolineatura e una rimarcatura della diversità dei ruoli e delle funzioni, tutte di pari dignità e meritevoli di reciproco, pari, assoluto rispetto, ma diverse nella loro essenza. Non è stata allora certamente la sua morte a impedirmi di sapere che cosa avrebbe detto e pensato di tutti i patteggiamenti, ristretti e allargati, in primo grado e in appello, di tutte le condanne a pena concordata senza dichiarazione di responsabilità che si sono succeduti nel tempo. I grandi come lui (e come altri magistrati: Guido Barbaro, Mario Carassi, per citare solo quelli a cui sono stato personalmente più vicino) continuano a parlare e farsi sentire, anche dopo la morte.
Ho però riesumato dal sacrario dei miei ricordi questi episodi e questi esempi solo per far comprendere come Bruno Caccia non fosse e non sia di nessuno, perché appartiene a un’altra sfera, a un’altra dimensione, ad altre altezze e a nessuno è consentito appropriarsene. Nessuno pronunci il suo nome invano.
In questa occasione desidero però aggiungere il ricordo di un ulteriore lascito di cui Bruno Caccia ci ha fatto eredi. Ed è la sua famiglia. Il destino ha voluto che qualche mese fa, proprio nel venticinquesimo anno dalla sua morte, sia mancata anche la sua indimenticabile compagna di vita e di passioni: la signora Carla, detta affettuosamente “Pupa”. In questi venticinque anni la signora Caccia ha non solo conservato, custodito, coltivato, in maniera esemplare e commovente, la sua memoria; ma si è sempre fatta, in ogni occasione, con una facondia e un eloquio certamente non inferiore a quello del marito, attiva e instancabile portatrice del suo messaggio e dei suoi valori: di onestà, probità, rettitudine, impegno, sacrificio, dedizione. Credo che sia sempre doveroso, da parte mia e di tutti, accomunarla sempre, d’ora in poi, nel ricordo del marito.
Leggi anche gli altri articoli dedicati a Bruno Caccia:
– “Il mio maestro Bruno Caccia”, di Giancarlo Caselli
– “Ceresole per noi, famiglia Caccia”, di Paola Caccia
– “Bruno Caccia, un servitore dello Stato”, di Piermario Demichelis
 QUESTO ARTICOLO E’ APPARSO SUL N. UNO di “Roero Terra Ritrovata”
QUESTO ARTICOLO E’ APPARSO SUL N. UNO di “Roero Terra Ritrovata”
PUOI SFOGLIARLO ONLINE QUI.